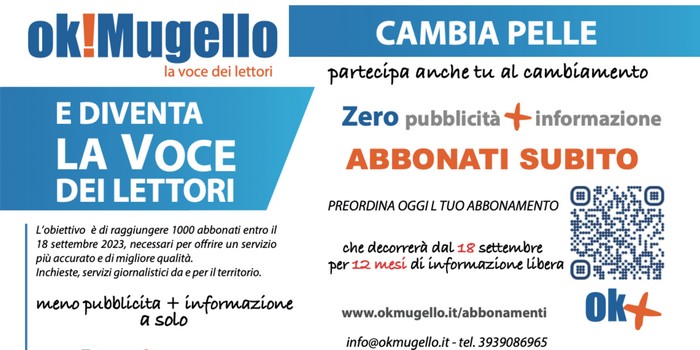Un dolcissimo Mugello
Un dolcissimo Mugello
Il Mugello, pur isolato da monti e boschi e per secoli contado fiorentino, è terra molto soggetta alle contaminazioni. Firenze, con la sua storia e la Signoria da un lato, la vicina Romagna con i suoi Signori dall’altro, la presenza della corte dei Medici, la grande devozione cristiana. Tutto questo ha influenzato, oltre che la storia e il carattere delle persone, anche la cucina mugellana. La grande tradizione dell’uso della carne, molta della quale arrivava a Firenze proprio dal Mugello, i primi piatti, che risentono dell’influenza romagnola, il lavoro di Pellegrino Artusi, che così come questa vallata, ha vissuto a cavallo tra Toscana ed Emilia-Romagna.
E ancora i piatti importati dai Medici, con cuochi di tutto il mondo che, in particolare con Caterina, portarono ad alcune importanti creazioni, utilizzate nei banchetti al Castello di Cafaggiolo e da qui, attraverso la locale servitù, passate nelle mense mugellane, magari rielaborate in base agli ingredienti a disposizione. Che erano spesso freschi e abbondanti, offerti dalle stagioni, per la necessità di fornire, oltre che un piatto gustoso, nutrimento ed energia per la dura vita dei campi. E poi i piatti segnati dalle feste, in particolare quelle religiose, con la necessità di nobilitare la tavola in onore del Santo Patrono oppure di onorare la fine dei periodi di vigilia. Una cucina povera ma di grande sostanza e di grande gusto, in cui la sapienza delle massaie, ha saputo rielaborare materie prime umili ma fresche, spesso raccolte dietro casa.
I dolci nella tradizione
Lo stesso è stato per i dolci. Uova, farina, latte, burro, marroni, miele, uva, frutta sono quasi sempre stati a disposizione delle tavole della zona, e il dolce era sinonimo di festa, nonché di integrazione e variazione a piatti che spesso si ripetevano con cadenza settimanale. E le case dei contadini erano dotate quasi tutte di forno dove, dopo la cottura del pane, a forno un po’ più tiepido, si cuocevano meravigliose torte secche, ideali colazioni o pause nell’intensa e dispendiosa giornata di lavoro.
Le feste di paese, quelle religiose, piuttosto che il Carnevale o le ricorrenze legate alla produttività della terra, erano anche occasione di gara tra le massaie, che preparavano dolci gustosissimi, con i quali si sfidavano, fino a tutto l’immediato dopoguerra. I dolci erano offerti all’uscita della Messa, spesso occasione per le più giovani anche per farsi notare dai giovanotti.
La stagionalità era preponderante: la vendemmia finiva con l’uva messa sulla pasta di pane per delle schiacciate con l’uva che ristoravano i lavoranti della vendemmia ed erano propiziatorie. Il freddo inverno era tempo per il marrone, specialmente sull’Appennino, frutto di facile conservazione, che veniva usato direttamente – essendo dolci di natura non necessitavano neppure di aggiunta di zucchero - o, una volta essiccato, come farina, in gustose preparazioni. La primavera, con l’arrivo della frutta, dei profumi, si presentava propizia per crostate, biscotti e dolci a base di riso. Nell’estate il latte e le uova erano prodotti in abbondanza e, complice la genialità di alcuni cuochi, si prestavano a creme e preparazioni rinfrescanti ma nello stesso tempo corroboranti.
E nei dolci, al di là della presentazione e della quantità, quasi sembrava ridursi la distanza tra ricchi e poveri, signori e contadini, in nome di una uniformità di gusti e di piaceri. La Torta in Balconata, per fare un esempio, da poco riscoperta, forse una delle più autoctone, ricca di spezie, frutta secca e candita, pur essendo nata alla Corte Medicea, si distribuiva anche tra i più poveri, magari con meno varietà di spezie, ma comunque gustosa.
Tale gusto per il dolce è rimasto fino ad oggi accompagnato da materie prime di assoluto valore e gusto che rendono questa produzione mugellana meritevole di una sosta se non di un viaggio, visto anche l’alto numero di forni e laboratori di produzione propria presenti sul territorio.
Le ricette tipiche
Nel recente passato un gruppo di appassionati ristoratori con l’Assessorato al Turismo della Comunità Montana hanno operato una selezione sulle ricette tipiche individuate da Tebaldo Lorini, esperto di tradizioni locali. L’obiettivo è quello di proporre per il futuro menù tipici nei ristoranti del territorio che valorizzino la tradizione gastronomica e i prodotti locali.
Tra le ricette di dolci di tradizione troviamo i biscotti secchi come i particolari zuccherini che riempivano le calze della Befana e fortificavano i denti dei bambini, i berlingozzi, ricetta che risale al Rinascimento e che prevede eccezionalmente la bollitura prima e la cottura poi, e le bocche di dama, preparate con uova, mandorle tritate e scorza di limone.
Per quanto riguarda le preparazioni al cucchiaio, un dolce diffusissimo nella zona, che veniva realizzato in ogni famiglia era il latte alla portoghese, adatto ad ogni pasto e preparato bollendo il latte con lo zucchero, la buccia di limone e la vanillina; una volta raffreddato si aggiungevano le uova sbattute e il composto veniva poi cotto nel forno a bagnomaria.
In una zona ricca di castagneti non potevano certo mancare i dolci a base di marroni. Tra i più noti possiamo ricordare il castagnaccio, distinguendo tra la ricetta povera –che oltre alla farina di castagne setacciata vedeva solo l’aggiunta di acqua, olio e rosmarino- e quella arricchita di uvetta, pinoli e gherigli di noci, non sempre presenti nelle case dei contadini. L’altro prodotto per eccellenza è la torta di marroni, ricetta più elaborata ma di grande gusto che consiste in un dolce impasto di marroni avvolto in una leggera sfoglia.
Sempre rimanendo in ambito torte, tra le ricette messe in evidenza da Lorini c’è la crostata di ricotta, un dolce ricco che si ottiene dall’impasto di ricotta, uvetta, uova, cedro candito, mandorle tritate, zucchero e rhum. Più semplice e legata all’attività della vendemmia è la schiacciata con l’uva che si realizza aggiungendo l’uva schiccata alla pasta di pane.
Grande tradizione anche quella del fritto. Nella scelta delle ricette compaiono le frittelle di mele e di riso per festeggiare rispettivamente San Biagio, protettore della gola, e San Giuseppe. Altra dolcezza molto diffusa soprattutto nell’Alto Mugello erano i tortellini fritti ripieni di un passato di marroni, rhum, alchermes e un poco di zucchero a velo.
Comunità Montana Mugello