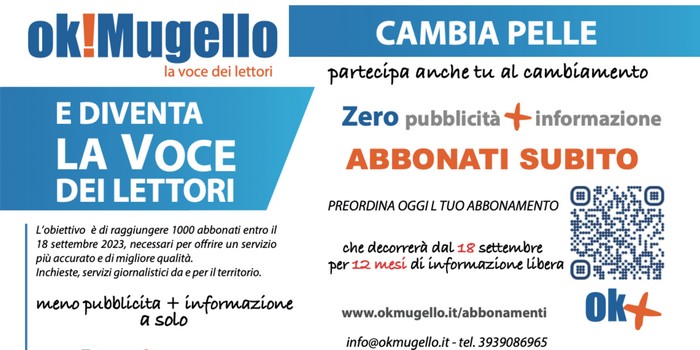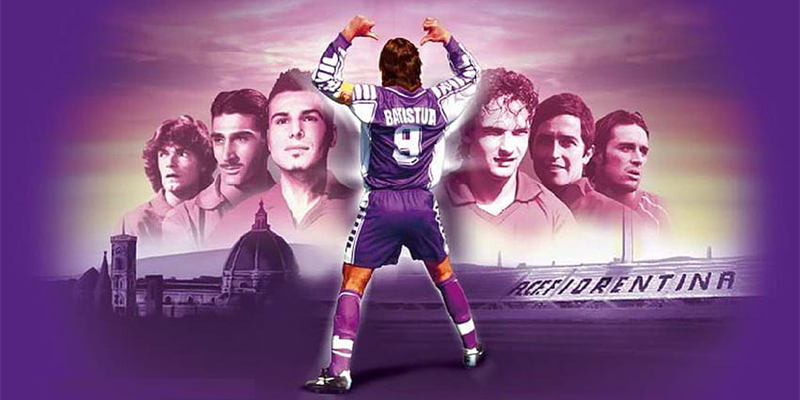Marradi: l'Abbazia di San Benedetto in Alpe. Storia e molto altro nell'articolo di un lettore... © n.c.
Marradi: l'Abbazia di San Benedetto in Alpe. Storia e molto altro nell'articolo di un lettore... © n.c.
L'articolo che segue è stato pubblicato su Annali Romagna 2012, supplemento al numero 67 di Libro Aperto, rivista diretta da Antonio Patuelli. Lo riceviamo dall'autore, Massimo Ragazzini, per la pubblicazione sul nostro sito. Buona lettura:
L'ABBAZIA DI SAN BENEDETTO IN ALPE
1. Premessa
San Benedetto in Alpe è noto come punto di partenza per l'escursione alla cascata dell'Acquacheta. Lo scrittore forlivese Marco Galizzi, in un recente e simpatico libro, ha scritto: “Anche solo una volta nella vita, se puoi, percorri il sentiero che da San Benedetto in Alpe, costeggiando il torrente Acquacheta, porta a uno dei luoghi più suggestivi dell'Appennino romagnolo. Un'acqua limpidissima tra rocce e gradoni per novanta metri di salto, la cascata dell'Acquacheta. Rimani in ascolto tra foreste di querce, castagni, faggi e sempreverdi, lascia che le musiche di quel palcoscenico colorato ti parlino a fondo della Romagna” (1).
Ogni anno sono moltissimi quelli che seguono il consiglio di Galizzi, specialmente in primavera, quando la portata del torrente è maggiore. Percorrono il sentiero abbastanza agevole, che conduce in un'ora e mezza circa davanti alla cascata. Attraversando il torrente, in pochi minuti si sale alla sommità della caduta dell'acqua, bellissimo punto panoramico che domina l'intera valle dell'Acquacheta, e alla Piana dei Romiti, vasto altopiano contornato dai monti.
Il fascino dei luoghi colpì e ispirò anche Dante Alighieri, che li citò nella Divina Commedia (2), paragonando la “caduta” dell'Acquacheta alla cascata del fiume infernale Flegetonte che separa il settimo dall'ottavo cerchio dell'inferno. Grazie a Dante l'Acquacheta ha conquistato imperitura fama letteraria.
Ma a chi vi si reca San Benedetto non ha solo da offrire la bellezza del proprio paesaggio. Vale la pena scoprire il piccolo nucleo superiore del paese, Poggio, che nasconde i resti di una delle più antiche Abbazie benedettine.
2. Dove si trova
Distante 45 chilometri da Forlì e 64 da Firenze, sul versante nord orientale dell'Appennino tosco romagnolo, San Benedetto in Alpe è l'ultimo paese della Romagna prima del passo del Muraglione.
Il paese, che deve il suo nome alla secolare Abbazia benedettina, è diviso in due parti:
- Mulino (m. 500 circa s.l.m.), così detto per i mulini che in antico vi esistevano, situato lungo la strada statale 67 nel punto dove i tre torrenti Acquacheta, Troncalosso e Rio Destro si uniscono dando origine al fiume Montone;
- Poggio (m. 600 circa s.l.m.), collocato su di uno sperone roccioso soprastante Mulino, dove sorge appunto il complesso abbaziale.
Poggio è collegato a Mulino da una strada lunga poco più di un chilometro e da un antico e ripido borgo, via Dante, suggestiva scorciatoia pedonale.
3. L'Abbazia. Com'è e com'era
Come tanti altri antichi edifici, il complesso abbaziale mostra componenti che risalgono a epoche diverse, dal medio evo ai primi decenni del XVIII secolo. Seguiamo un percorso a ritroso nel tempo e osserviamo per primo l'interno dell'attuale chiesa.
L'iscrizione di una lapide vicina alla porta di ingresso attesta che i lavori di ricostruzione della chiesa furono completati nel 1723. La chiesa è ad aula unica. Il tetto è sostenuto da capriate lignee. Cinque gli altari addossati alle pareti con colonne laterali di stile rinascimentale coronate da capitelli corinzi.
Il primo altare a destra dell'entrata ospita un quadro raffigurante Sant'Antonio abate. Secondo Paolo Bandini “il quadro è molto antico e forse risale all'epoca del Monastero” (3). Il primo altare di sinistra ospita, in una nicchia, una statua raffigurante la Madonna. Sopra questi due altari sono dipinti gli stemmi di due famiglie locali.
Il secondo altare a destra contiene un quadro che raffigura la Madonna del rosario. Da un'iscrizione sul quadro medesimo ricaviamo che il quadro risale al 1633. L'immagine della Madonna è contornata da 15 quadretti rappresentanti i misteri del rosario. Il Bandini ritiene che anche questo dipinto sia appartenuto all'antica Chiesa (4).
In una nicchia dell'altare maggiore è ospitata una statua della Madonna col Bambino. Nei mesi invernali, tuttavia, la nicchia è vuota perché la statua viene collocata nella chiesa di Mulino.
Nelle due colonne laterali dell'altare maggiore, sopra i capitelli, sono scolpiti due grandi vasi dai quali si sprigionano fiamme.
In alto, davanti all'altare maggiore, è stato collocato un crocifisso ligneo scolpito e dipinto che, secondo Enzo Donatini, è di scuola fiorentina del Quattrocento (5).
Nella parte destra della chiesa, una nicchia fra l'ingresso e l'altare con Sant'Antonio ospita un pregevole manufatto, un fonte battesimale costituito da una grande vasca di marmo che poggia su una colonna di pietra. Dei medesimi materiali è stata realizzata la pila per l'acquasanta.
La chiesa nasconde però molto più di quello che mostra.
Occorre quindi fare alcuni passi indietro nel tempo. La chiesa venne ricostruita perché alcune parti del precedente edificio erano collassate. Ma non fu ripristinata nelle sue precedenti linee architettoniche, le cui caratteristiche sono sufficientemente note e ribadite anche dalle risultanze di uno scavo archeologico effettuato nel 1987 a cura della Sovrintendenza ai beni archeologici.
La forma originale della chiesa antica era a croce latina. Nella loro relazione i responsabili degli scavi Sauro Gelichi e Valerio Brunetti confermano che “la navata centrale terminava con abside semi circolare mentre i bracci del transetto erano semicircolari all'interno e forse rettilinei all'esterno” (6). L'antica chiesa aveva una grande cripta posta sotto il presbiterio e l'altare maggiore, con diramazione sotto i due transetti. Il complesso abbaziale comprendeva anche il convento, il chiostro e un sistema fortificato.
Il Capitolo della Basilica di San Lorenzo di Firenze, al quale la chiesa era stata concessa nel 1526, decise di abbattere il muro e la cappella di sinistra e di ricostruirla spostandola tutta sulla destra demolendo così metà del chiostro dell'antico monastero. Osserva in proposito Ugo Maestri nel suo saggio sulla storia del paese: “In tal modo la nuova chiesa viene a risultare più piccola della vecchia, non ha più la forma della croce latina, perde il pregio dell'abside, della cripta e delle cappelle sull'asse minore della croce” (7).
L'ampia area che era occupata dalla vecchia chiesa diventò un campo e poi un prato. Oggi l'area è prevalentemente sterrata e necessita di un incisivo intervento di miglioramento.
L'originario edificio medioevale non è andato però completamente perso. Le parti dell'Abbazia che si sono conservate valgono una visita a San Benedetto, anche a prescindere dall'escursione alla cascata dell'Acquacheta. Sono anche oggi visibili:
- il muro perimetrale destro, inglobato e riutilizzato nella nuova chiesa. Vi si riconoscono l'arco di accesso dal presbiterio al transetto e una porta con arco a tutto sesto;
- l'alto campanile a vela;
- l'attacco dell'abside semicircolare;
- il grande arco di accesso al pronao, già di ingresso al convento e ora alla chiesa;
- un vano con soffitto voltato a crociera a ridosso del presbiterio;
- una torre di vedetta munita di feritoie balestriere;
- elementi (le colonne di pietra) di una porzione del chiostro con il pozzo, ora non più centrale ma addossato al muro della chiesa;
- la cripta del transetto di destra.
Ed è proprio la cripta che più impressiona il visitatore.
4. La cripta
La maggior parte della cripta dell'antica chiesa è rimasta coinvolta nella demolizione settecentesca. Ma è rimasta intatta, ed è tuttora molto suggestiva, la parte corrispondente al transetto di destra.
Il Bandini la descrive “a forma quasi quadrata, con quattro archi sorretti da due artistiche colonne, alte, senza il piedistallo e il capitello, m. 1,25 e con una circonferenza ai due capi di cm. 86. Le colonne sono a forma quadrata, coi lati slabbrati, in modo che assumono la forma ottagonale. Tali colonne sono piantate nel centro della cripta, sono sormontate da capitelli che imitano lo stile bizantino. Da ciascun capitello partono quattro archi che vanno ad appoggiarsi
sulle colonne aderenti al muro e toccano terra. L'arco che va verso l'altra colonna poggia sull'altro capitello, e quello che va verso la piccola finestra si biforca e poggia, lateralmente alla finestra, in una colonna adiacente al muro fino a terra. Da ciascun capitello partono ancora altri quattro crinali dirigentesi al centro dell'arco e formanti volte a botte e a crociera” (8). La cripta ospita ora le presunte reliquie dei martiri cristiani Primo e Feliciano, che in precedenza erano collocate sotto l'altare maggiore.
Gli scavi archeologici del 1987, compiuti in una porzione dell'area dove sorgeva l'antica chiesa, hanno messo in luce i resti della parte centrale della cripta, che è risultata suddivisa in tre navate da pilastrini ottagoni con terminazione quadrata, in arenaria, su cui poggiavano capitelli a tronco di piramide. L'accesso si apriva sulla navata mediante due scale disposte simmetricamente.
Si può ora entrare nell'area degli scavi attraverso la parte di cripta rimasta intatta.
5. Il dibattito sulle origini
Non ci sono documenti che ci indichino con certezza quando ebbe origine l'insediamento monastico e quando fu eretta l'Abbazia. Qualche indicazione sulla datazione dell'edificio ci viene dai responsabili degli scavi del 1987, i quali, pur premettendo che “nessun documento né dato materiale ci informa circa la cronologia dell'edificio”, così concludono: “Da un punto di vista strutturale la cripta nasce intorno alla chiesa, non appartiene cioè ad un edificio preesistente. Una datazione intorno alla prima metà del secolo XI potrebbe indizialmente essere proposta” (9). Il dibattito sull'argomento è stato intenso e molto ben illustrato in un recente e documentatissimo libro di Giuseppe Rainetti (10) che consigliamo a tutti gli interessati. In questa sede accenniamo solo al fatto che sono numerosi i documenti antichi che riguardano, o comunque citano, l'Abbazia di San Benedetto in Alpe. Le fonti relative all'Abbazia risalgono agli inizi del secolo XI, anche se l'esistenza di un nucleo di eremiti in questa zona può essere assegnata a periodi precedenti. É documentato che, grazie a donazioni e acquisti, quella di San Benedetto in Alpe era nel XII secolo una delle più ricche e potenti abbazie dell'Appennino tosco-romagnolo. I possedimenti dell'Abbazia si estendevano nelle diocesi di Forlì, Forlimpopoli, Faenza e Firenze. Il monastero raggiunse l'apice della sua influenza durante il XIII secolo, quando anche i fabbricati che lo componevano assunsero notevoli dimensioni: tutta l'area dell'attuale abitato di Poggio era infatti allora probabilmente occupata dalle celle dei monaci, le quali su due file formavano un borgo ai lati della strada rettilinea che ancora oggi parte dalla chiesa abbaziale. I secoli XIV e XV segnano la decadenza dell'Abbazia, che vede progressivamente diminuire i suoi monaci, finché nel 1499 l'Abate di San Benedetto consegna i pochi beni e i privilegi che ancora l'Abbazia possedeva nelle mani di Papa Alessandro VI. Il Maestri così riassume gli eventi dei secoli successivi: “Come prima conseguenza viene soppresso nell'Abbazia l'Ordine benedettino e nell'anno 1500 l'unico monaco rimasto ha il solo compito delle funzioni proprie della chiesa. Così finisce la vita e l'autonomia della grande Abbazia di San Benedetto. Dopo essere passata all'amministrazione dell'Abbazia di Vallombrosa nel 1526 viene concessa per sempre al Capitolo della basilica di San Lorenzo” (11). Ridotta l'Abbazia a semplice parrocchia, i fabbricati furono trascurati, con la conseguenza che abbiamo sopra visto.
6. Le antiche pergamene
Gli studiosi che vogliono approfondire la storia dell'Abbazia di San Benedetto in Alpe e del suo territorio possono consultare le pergamene del monastero. Da questi documenti si ha la prova dell'importanza e del prestigio che aveva l'Abbazia. Il fondo monastico è custodito presso l' Archivio Capitolare della Basilica di San Lorenzo in Firenze ed è collocato nella prima delle quattro grandi sezioni nelle quali è suddiviso l'archivio (12). Si tratta di 165 pergamene la maggior parte delle quali risalenti ai secoli dal XII al XV. A questo fondo vanno aggiunte due carte di enfiteusi custodite nell'Archivio Arcivescovile di Ravenna, una Bolla papale di Callisto II datata 1125, edita nel Bullarium Laurentianum, e un atto del 1103 conservato presso l'Archivio di Stato di Firenze. Una parte del fondo è stata pubblicata dal Bandini (13). Di particolare rilievo lo studio, più recente, svolto a cura dei paleografi Bruno Gurioli e Silvia Tagliaferri (14).
7. Conclusione
Conosciuta e studiata dagli storici, dai letterati e dagli storici dell'arte, l'Abbazia di San Benedetto in Alpe è poco nota al grande pubblico. Chi scrive si augura che queste sommarie notizie possano avere stimolato l'interesse per una visita del luogo.
Infine un consiglio per i visitatori. Per accedere al chiostro-cortile con pozzo (che oggi è un piccolo e delizioso giardino curato dalle signore Domenica e Giovanna Rabiti), e poi da lì alla cripta, bisogna entrare dalla prima porta a destra dell'ingresso della chiesa. Il cortile è anche un terrazzo per ammirare il panorama della valle e dei monti che la circondano. Non perdetevelo.
Massimo Ragazzini
NOTE
(1) Marco Galizzi, Lo zen della tagliatella romagnola, Il Ponte Vecchio, Cesena, 2011, p. 97.
(2) Inferno, Canto XVI, 94-105.
(3) Paolo Bandini, S. Benedetto in Alpe e la sua secolare Abbazia, Raffaelli, Forlì, 1934, p. 64.
(4) Paolo Bandini, cit., p. 65.
(5) Enzo Donatini, Confluenze artistiche nel territorio, ne Il Parco del crinale, tra Romagna e Toscana, Alinari, Firenze, 1992, p.104.
(6) Sauro Gelichi e Valerio Brunetti, Notizie sullo scavo della cripta della chiesa abaziale di San Benedetto in Alpe ne “I quaderni dell'Acquacheta, 2”, Pedanesi, Roma, 1988, p. 114.
(7) Ugo Maestri, Breve storia di San Benedetto in Alpe, Pierguidi, Rocca San Casciano, 1991, p. 7.
(8) Paolo Bandini, cit, pp.70 e 71.
(9) Sauro Gelichi e Valerio Brunetti, cit., p.114.
(10) Giuseppe Rainetti, L'Alpe di San Benedetto e la sua Abbazia, ASKA, Firenze, 2010.
(11) Ugo Maestri, cit, p. 6.
(12) vedasi il sito web www.operamedicealaurenziana.it
(13) Paolo Bandini, cit., pp. 29 – 48.
(14) Bruno Gurioli, Silvia Tagliaferri, Per l'edizione delle carte del Monastero di San Benedetto in Alpe in L'alta Valle del Montone, Deputazione storia patria per le province di Romagna, Documenti e studi, Vol. XXXVII, Bologna, 2006, pp. 23-38.