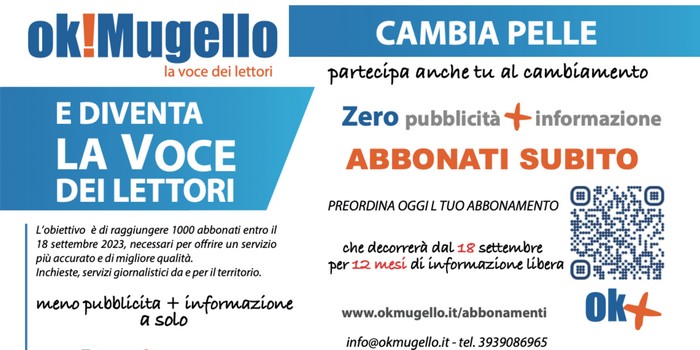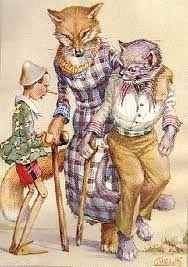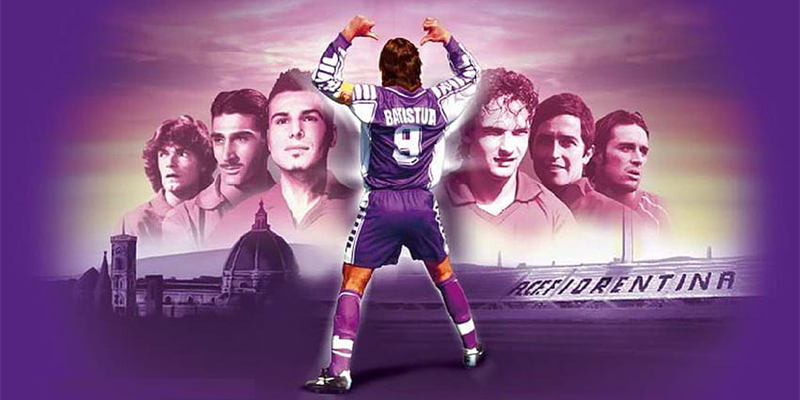Il Gatto e la Volpe di Pinocchio? Personaggi ispirati dal mugellano Pananti. La vera storia... © n.c.
Il Gatto e la Volpe di Pinocchio? Personaggi ispirati dal mugellano Pananti. La vera storia... © n.c.
Abbiamo tutti, in un determinato periodo della nostra vita, letto “Le avventure di Pinocchio la Storia di un Burattino” scritta dalla fervida e fantastica mente del Collodi.
Quante volte da piccoli dopo aver inventato qualche bugia per nascondere qualche marachella, dalle nostre mamme o nonne ci siamo sentiti raccontare le vicissitudini capitate alla famosa marionetta di legno? E del “Grillo Parlante”, “La Fata Turchina”, “Mangiafuoco”ne vogliamo parlare..?
Collodi, al secolo Carlo Lorenzini, scrisse il suo romanzo basandosi su personaggi immaginari o realmente vissuti? I vari “Mastro Geppetto” e “Lucignolo”uscirono immaginariamente dalla sua penna o si ispirò a persone conosciute magari tra le strade di una ottocentesca Firenze o altrove?
Galleria fotografica
Di una cosa siamo quasi certi, (il quasi è d’obbligo in questi casi), per le figure del “Gatto e la Volpe” l’autore di Pinocchio prese spunto da quello che scrisse un poeta mugellano ben sessant’anni prima. Ma andiamo con ordine.
Carlo Lorenzini, non ancora famoso, per guadagnarsi la vita iniziò a lavorare come commesso nella libreria Piatti di Firenze e in quelle stanze, tra scaffali pieni di libri, odore di carta, poca luce e un po’ di polvere, nei ritagli di tempo leggeva. Un giorno riposto in una dimenticata mensola trovò un testo dal titolo interessante: “Avventure e Osservazioni Sulle coste di Barberia” del Dott. Filippo Pananti edito proprio dalla stamperia-libreria Piatti qualche anno addietro. Questo era un resoconto di un avventuroso viaggio per mare scritto dal famoso Pananti, l’arguto epigrammatico nato nel Mugello, il quale nella sua vita non scrisse solamente motti e poesie. Nelle “Avventure” l’autore racconta con dovizia di particolari, i numerosi imprevisti che gli capitarono durante la traversata in mare a bordo di un brigantino trapanese, che avrebbe dovuto riportarlo in patria dopo anni di assenza. La nave fu dirottata dai pirati, ancorata ad Algeri e tutti i passeggeri compreso l’equipaggio rinchiusi nelle galere africane; Filippo rimase in prigione per poco, infatti grazie all’intercessione del console inglese poté essere liberato e con calma ripartire alla volta della Sicilia. Queste“disavventure” marine crearono al povero scrittore, cresciuto tra gli ameni poggi della campagna toscana, non poca paura e appena a casa decise di mettere nero su bianco il reportage di quello che gli era capitato.
Tutto cominciò per colpa di due “falsi amici” come scrive in un capitolo iniziale della sua opera. A Londra Filippo conobbe due suoi compatrioti che di li a poco, dopo aver guadagnato la sua fiducia, riuscirono a spillare al malcapitato una numerosa quantità di denaro. Ma lasciamo la parola al narratore: “Ed io sembra che fossi la calamita di tutti i vagabondi. Erano per mala disgrazia da casa della malora caduti in Londra quel furbaccio di N. X Palermitano, N. Y, altro bel Fiore di virtù. Queste due Volpi vecchie tosto divennero come pane e cacio, come due anime in un nocciolo. […] Costoro guardaron tosto se c’eran quaglie da far venire alla rete, e dove si poteva fare un buon botteghino. Il minchione (e son io). Io dovetti levarmi il pan di bocca per darlo a loro […]L’X era una bocca melata, un’aria da mammamia; ma quando parlava, non guardava in faccia nessuno e aveva un occhio guercio: cave a signatis. L’Y. Poi si fece avanti con quella faccia invetriata che non arrossirebbe se gli spuntasser le corna; anch’esso sapeva far la gatta di Masino, e parlava così caldamente di virtù e di morale, che uno si sarebbe confessato. Oh! A cercarli col fuscellino poteva io peggio inciampare![…] Ho domandato al mio compatriota l’Y, quale buon vento vi portò qua. Questo famoso istrione mi rispose col verso di Virgilio: infandum Regina iubes renovare dolorem […]Intesi subito ove andava a finir questa antifona, voleva ch’io dessi intanto qualcosa, in prestito s’intende per un mese, per due alla più lunga: mi vuol rendere tutto fino all’ultimo picciolo. E come non fidarsi di un uomo così delicato [...]. Attirato dall’odore, e saputo essere il terren morbido, venne allo stesso attacco l’X. […] il fido Alcete mi assicurò essere il figlio di un Signore Palermitano il quale sguazzava nell’oro, ed esso il fiore dei galantuomini, mi promette che era una delizia: domandando al compagno mio, ti darà quel che ho detto io. Dateci venti lire, non ne ho che sette. Dateci allora queste sette, le altre tredici ce le troverete, è permesso appoggiarsi agli amici, ma non buttarli per terra. I denari io non li zappo, mi costano gocce di sudore, che dubbi son questi? Rischiate forse qualcosa, forse non ci conoscete?”
Intanto i due furboni, con i soldi del Pananti, fecero bagordi in osteria, brindando alla salute del loro ingenuo benefattore, il quale, forse, accorgendosi della mala parata, cercò con tutti i mezzi di discostarsi dagli infidi nuovi affezionatissimi amici. Decise, dunque, di partire e di tornare a casa, e data la sua poca simpatia verso il mare, prese in anticipo accordi con un bastimento comandato da un capitano serio e scrupoloso: “Si era stabilito di navigare sopra un legno Inglese; ma l’ (AVV.) Y. scambiò tutto: quell’impiccione scavò di non so dove un Brigantino di Trapani”. Non solo, ma i Signori X e Y si assicurarono di imbrogliare un’ultima volta il facoltoso poeta promettendo facili e redditizi investimenti del suo denaro in fantastiche operazioni commerciali, e dopo aver firmato fittizi fogli volanti si congedarono dal poveretto dando un futuro appuntamento in Italia. Il Pananti partì, la nave non battendo bandiera inglese venne assaltata dai corsari, i passeggeri derubati e portati in prigione. Passati alcuni mesi, dopo essere tornato a casa, Filippo cercò di contattare i due vecchi amici ora creditori: “ Ora che furon dei miei denari prestati a quei due Signori? Dei miei mille scudi non più si è fatta parola. Certe galanterie certi animaletti che gli confidai, pregandolo di portarli a Palermo, ove presto mi sarei recato, quel perfido uomo appena arrivato a Lisbona vendé tutto per pochi denari.[…] Ma l’X almeno si tien nascosto non mi dice: non vé le vuò a dare, da me che avete da avere? Come fa il garbato Signor Y”.
Come i personaggi che imbrogliarono “Pinocchio” anche l’X e Y finirono male, chi in galera, chi malato al campo santo.
Lorenzini lesse le vicissitudini panantiane e la sua favolosa immaginazione fece il resto, i Signori X e Y divennero “il Gatto e La Volpe”, molto simili per aspetto ed ipocrisia ai “falsi amici” illustrati da Filippo.
Ma a questo punto ci si potrebbe chiedere, chi erano in verità gli antesignani imbroglioni ispiratori del Collodi, passati alla ribalta della letteratura mondiale?
Per anni l’impenetrabili sigle di X e Y lasciarono spazio solamente ad azzardate e improbabili ipotesi. Il mistero durò fino al 1897, quando Luigi Andreani serio e colto bibliotecario rontese, scoprì nelle carte del Pananti e poi pubblicò i nomi, aggiungendoli ai cognomi – accennati in appendice ad una delle varie edizioni delle “Avventure”- delle due misteriose macchiette: Y era l’Avv. Gustavo Adolfo Braccini di Firenze e l’X Nicola Auteri di Palermo.
Chissà se questi due Signori avranno mai immaginato di diventare un giorno i personaggi di uno dei racconti per bambini, e non solo, più famoso al mondo.
Pier Tommaso Messeri